Johannes Petry e Andreas Nölke, “BRICS and the Global Financial Order: Liberalism Contested?” Cambridge University Press, Cambridge, 2024, pagg. 102
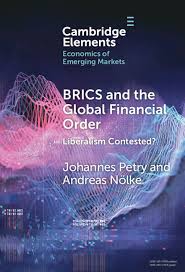
Dagli anni Novanta in poi il peso dei BRICS è cresciuto fino a rappresentare un quarto del Pil globale. Con quale ricetta economica ci sono riusciti? Quali modelli alternativi propongono?
L’analisi del peso mondiale dei sistemi e delle istituzioni finanziarie che fanno capo ai Paesi “BRICS”, con i loro modelli alternativi a quello occidentale, è al centro del presente volume. Secondo quanto sostenuto da Petry e Nölke, contrariamente ad altri ambiti dell’economia, il ruolo fondamentale della finanza non sempre viene adeguatamente soppesato in modo da favorire disamine accurate dei sistemi economici contemporanei. Il fine degli Autori è segnalare questa lacuna, per poterla risolvere non tanto per supportare di per sé la finanza globale alternativa, più accentrata grazie ad un maggiore ruolo dello stato, quanto per comprenderne meglio le dimensioni e la posizione sullo scacchiere mondiale.
Il volume illustra sinteticamente il dibattito su ampia scala, teso a mettere in discussione l’ordine finanziario globale dominante (ingl., global financial order). Come spiegano Petry e Nölke, si tratta di una vera e propria “contestazione”, che si è sviluppata di pari passo con la crescente rilevanza delle economie di mercato emergenti nella cornice mondiale, ed è legata al consolidamento negli anni delle economie “BRICS” (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).
Come viene ricordato nel libro, le economie dei mercati emergenti hanno già assunto un ruolo considerevole nel contesto internazionale: tra il 1990 e il 2020, il contributo dei BRICS al PIL globale è aumentato dal 7,9% al 24,7%. Il trend è proseguito anche nel periodo recente. Inoltre, come ci evidenzia la letteratura scientifica, alcuni Paesi hanno registrato uno progresso senza precedenti: si pensi, ad esempio, al considerevole sviluppo del mercato dei capitali cinesi dagli anni Novanta in poi (Hu et al., 2018).
In base all’analisi incentrata sui Paesi più rappresentativi, gli Autori tratteggiano le modalità e l’efficacia con cui i Paesi BRICS stanno tentando di mettere in discussione l’ordine finanziario dominante. A loro detta, è possibile osservare che i BRICS sono stati mediamente abili a non conformarsi alle norme e alle regole che sono invece alla base dell’architettura finanziaria di tipo liberale. Puntualizzato ciò, risulterebbe che, più che l’intero blocco BRICS, ad opporsi al modello finanziario liberale angloamericano siano stati soprattutto tre grande Paesi, che sono anche quelli trainanti: la Cina, l’India e la Russia.
Il volume ha alcuni elementi di forza, tra tutti la capacità di stimolare nel lettore una riflessione riguardo l’evoluzione dei mercati finanziari internazionali, in riferimento ai cambiamenti che si sono susseguiti dal 1990 in poi. In particolare, ciò aumenta la consapevolezza del fatto che al modello finanziario capitalistico occidentale si sono affiancati altri sistemi concorrenziali, la cui rilevanza è aumentata negli anni. Dall’altro lato ci sono delle puntualizzazioni da fare, ovvero delle osservazioni da muovere al testo sia sul piano metodologico-concettuale che su quello contenutistico, nonché verso gli assunti da cui gli Autori muovono l’analisi. Di seguito ne propongo alcune.
Alla base degli argomenti proposti nel volume c’è l’idea che lo sviluppo dei nuovi modelli finanziari nei mercati emergenti sia riconducibile al bisogno di bilanciare il potere finanziario sul piano internazionale. Non risulta invece alcun esame sull’ipotesi riguardo il fatto che lo sviluppo di un sistema finanziario “parallelo” a quello liberale possa essere stato concepito come ripiego, ovvero in risposta a delle politiche troppo restrittive (e talvolta dichiaratamente ostili) degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei Paesi europei verso i Paesi emergenti.
Verosimilmente, una delle principali spinte per l’adozione dei modelli finanziari alternativi nei Paesi emergenti è arrivata in risposta alle scelte strategiche degli USA, nonché dei loro alleati, nei confronti di alcuni importanti intermediari finanziari. Un esempio eloquente è riconducibile a casi come quello del “Banco Delta Asia”, con sede a Macau, che nel 2007 venne sanzionato per la conduzione di presunti affari illeciti con la Corea del Nord. Alla banca, che è rimasta nella “black list” del Dipartimento del Tesoro statunitense, senza l’autorizzazione per effettuare transazioni in dollari, è stato bloccato l’accesso ai conti e depositi presso le banche internazionali. Secondo alcuni esperti (per es. Farrell e Newman, 2023), in realtà il monito era rivolto essenzialmente alla Cina, che, da canto suo, avrà tratto un ulteriore incentivo per sviluppare delle infrastrutture proprie, con una rete finanziaria autonoma.
Un secondo esempio è riconducibile alla posizione della Federazione russa, che risulta in cima alla classifica dei Paese più sanzionati, nonostante l’effetto discutibile di tali misure (Lakicevic, 2025). Dal 2014 numerosi Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Unione Europea ed alcune organizzazioni internazionali, hanno imposto alla Russia delle sanzioni – anche finanziarie –, in seguito alle operazioni di annessione della Crimea. Per aumentare la pressione, dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Ue ha imposto nuove sanzioni, in una misura senza precedenti, che hanno riguardato anche le banche e gli oligarchi russi, tra cui Igor Sečin di Rosneft e il magnate Roman Abramovič, per anni proprietario del Chelsea Football Club.
Considerando che si potrebbe estendere il novero di simili esempi ad lungo elenco, è sensato interpretare lo spostamento degli affari russi negli ultimi anni, ed i relativi flussi finanziari, con il suo avvicinamento alla Cina, come la logica conseguenza del raffreddamento dei rapporti con i membri dell’Unione europea (in primis la Germania) e con il Regno Unito, nonché con gli Stati Uniti (perlomeno durante la presidenza di Joseph Biden). C’è poi una chiara volontà, da parte di alcuni Paesi, di adottare strumenti e canali alternativi – si pensi alla proposta avanzata proprio dalla Russia e discussa con i governi BRICS di adottare un modello diverso dallo SWIFT, per aggirare le sanzioni e le restrizioni, tra cui la disconnessione nel 2022 delle banche russe dal suddetto sistema.
In conclusione, dato che le dinamiche al centro del libro non vengono analizzate dal punto di vista di un processo di adattamento dei Paesi BRICS (Santiago e de Castro, 2025), è possibile sostenere che gli Autori pongano eccessiva importanza sulla volontà e la libera scelta dei Paesi “BRICS” di sviluppare un proprio modello finanziario in maniera autonoma, in grado di contrapporsi all’ordine liberale occidentale, che, in ultima istanza, viene pur considerato quello dominante.
Al di là di questo limite, si tratta di un testo informativo, ricco di spunti stimolanti. Pertanto, è di sicuro interesse per chi si dedica agli approfondimenti sui temi dell’economia politica e della finanza, per chi studia l’evoluzione dei sistemi finanziari mondiali, ed altresì per chi vuole iniziare a ridisegnare rapporti più cooperativi tra gli stati mondiali.