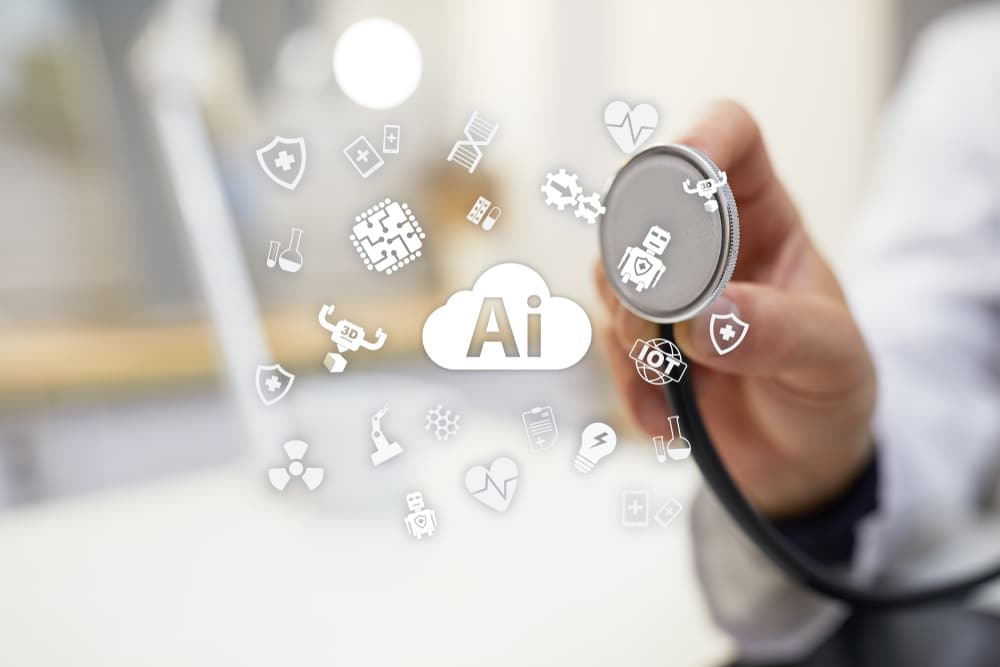
In un contesto in cui la popolazione invecchia, le cronicità aumentano e le risorse pubbliche non possono crescere all’infinito, la tecnologia diventa un alleato strategico. Ma la condizione è che venga usata non come fine a sé stessa, bensì come strumento per ricostruire un patto tra medicina e società


Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale (AI) ha fatto irruzione nella sanità, cambiando non solo il modo di diagnosticare e curare, ma anche quello di prevenire. Se fino a ieri la medicina si concentrava sul trattamento delle malattie già manifeste, oggi la disponibilità di dati e gli algoritmi di machine learning promettono, almeno in via teorica, di anticipare la malattia, intercettando i segnali deboli che precedono la comparsa dei sintomi. Di questi temi trattiamo ampiamente con analisi e proposte nel numero di Economia italiana appena uscito.
Incrociando dati clinici, genetici, ambientali e perfino comportamentali, l’AI è in grado di individuare pattern invisibili all’occhio umano. “Il valore aggiunto dell’AI sta nella capacità di leggere in anticipo i segnali che sfuggono ai metodi tradizionali”, sottolineano gli autori del capitolo. Questo apre la strada a diagnosi precoci, terapie personalizzate e, soprattutto, potrebbe portare a un significativo contenimento dei costi sanitari futuri: una malattia prevenuta o bloccata nelle sue prime fasi pesa molto meno sul sistema rispetto a una già avanzata – o, riecheggiando Benjamin Franklin, “An ounce of prevention is worth a pound of cure”.
Ma l’impatto dell’AI non riguarda solo il rapporto medico-paziente. Uno degli ambiti più promettenti è quello della gestione dei sistemi sanitari: l’AI non è solo un supporto clinico, ma una leva di governance. Algoritmi predittivi sono già utilizzati per stimare i picchi di domanda negli ospedali, pianificare i turni del personale e ottimizzare la distribuzione delle risorse.
In un Paese come l’Italia, con una popolazione tra le più anziane d’Europa e con una spesa sanitaria sotto costante pressione, la possibilità di programmare in modo più efficiente diventa cruciale. Un esempio arriva dal Regno Unito, dove il National Health Service ha sperimentato sistemi di AI per prevedere i ricoveri urgenti, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione dei Pronto Soccorso. Applicazioni simili potrebbero alleggerire le criticità anche del nostro SSN, spesso messo in difficoltà da improvvisi picchi influenzali o emergenze stagionali.
Un altro cambiamento epocale riguarda lo spostamento delle cure dall’ospedale al territorio. Grazie a dispositivi indossabili, sensori domestici e app di monitoraggio, l’AI permette un controllo continuo delle condizioni di salute, soprattutto per i pazienti cronici e gli anziani. Insomma: la sanità del futuro non sarà confinata alle mura ospedaliere, ma diffusa nei luoghi della vita quotidiana.
In Italia si moltiplicano i progetti pilota: dalle piattaforme per monitorare a distanza i pazienti diabetici, alle app che segnalano in tempo reale anomalie cardiache. Questi strumenti riducono gli accessi impropri agli ospedali e consentono un’assistenza più personalizzata e proattiva. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un nuovo modello culturale che mette il paziente al centro, rendendolo parte attiva nella gestione della propria salute.
Naturalmente, le promesse dell’AI portano con sé anche nodi complessi. Il primo riguarda la protezione dei dati: più informazioni vengono raccolte e integrate, maggiore è il rischio di violazioni della privacy. C’è poi il tema della trasparenza degli algoritmi, spesso percepiti come “scatole nere” di difficile interpretazione, e quello del rischio di amplificare disuguaglianze già esistenti se l’accesso alle nuove tecnologie non sarà garantito a tutti.
“L’AI non è una bacchetta magica: può migliorare la salute collettiva solo se inserita in una cornice di governance chiara e condivisa”, avvertono gli autori. Servono investimenti per integrare queste soluzioni nei modelli organizzativi, formare il personale sanitario e aggiornare i processi clinici. Un cambiamento che non riguarda solo la tecnologia, ma anche le competenze e la cultura professionale.
La vera rivoluzione sta dunque nel cambio di paradigma. Non basta introdurre strumenti più sofisticati: bisogna ripensare il rapporto tra paziente, comunità e sistema sanitario. L’AI spinge a superare un modello basato sulla reattività – curare quando la malattia si manifesta – verso uno basato sulla proattività: prevenire, gestire in anticipo, coinvolgere il cittadino.
È un passaggio decisivo per la sostenibilità dei sistemi sanitari. In un contesto in cui la popolazione invecchia, le cronicità aumentano e le risorse pubbliche non possono crescere all’infinito, la tecnologia diventa un alleato strategico. Ma la condizione è che venga usata non come fine a sé stessa, bensì come strumento per ricostruire un patto tra medicina e società. In questa direzione il progetto DARE, cofinanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, ha già avviato iniziative concrete e promettenti, sviluppando modelli di prevenzione digitale e partecipata che dimostrano la forza di questo nuovo approccio. Tali modelli vengono messi a disposizione degli attori del sistema nazionale della prevenzione – in primo luogo le Regioni, protagoniste delle politiche attive sul territorio – per favorirne l’adozione, la personalizzazione e il cambiamento di scala.
Le esperienze raccolte nell’articolo mostrano che la strada è già tracciata, ma richiede coraggio e visione. Se ben governata, l’AI può rendere la sanità più sostenibile, più equa e più vicina ai bisogni reali delle persone. La sfida non è decidere se adottare l’AI, ma come farlo in modo responsabile, inclusivo e lungimirante.
La sostenibilità della sanità italiana, e non solo, potrebbe dipendere proprio dalla capacità di affrontare questa sfida: usare l’intelligenza artificiale non solo per curare meglio, ma per costruire un sistema più resiliente, capace di prevenire e gestire le complessità del nostro tempo.